Per sette anni ho avuto la pretesa di fare critica letteraria — con un blog.
Nel 2010 avevo diciassette anni e amavo parlare di libri in modo non superficiale. Avevo notato che i primissimi spazi virtuali dedicati ai libri gestiti dai miei coetanei o da persone poco più grandi parlavano solo di urban fantasy young adult, il genere che allora andava più in voga. A me, invece, piacevano i classici, e così lo scrissi proprio: qui, al contrario che altrove, troverete solo libri seri.
A ripensarci mi scappa da ridere, perché pur essendo un’adolescente avevo in me il moralismo di un sessantenne che depreca la scarsa profondità delle nuove generazioni. Questo tipo di snobismo è perdonabile in una ragazza che aveva bisogno di sicurezze — i libri seri, a quanto pare, erano tra queste — ma non in quegli adulti che hanno il dovere di rendersi conto della realtà in cui viviamo.
Il numero di TuttoLibri del 15 marzo è dedicato alla morte della critica letteraria — abbassate il sopracciglio, per favore — con tre articoli a firma di Gianluigi Simonetti, Mario Baudino e Gilda Policastro.
Simonetti, che nell’economia del numero prende lo spazio più ampio, è un ottimo critico: ho letto il suo Caccia allo Strega (nottetempo) e l’ho trovato un brillante esempio di come si possa fare critica letteraria oggi. In questo pezzo intitolato “L’età dell’insofferenza per i ‘discorsi secondi’” la tesi è la perdita di autorità della critica a causa della pervasività della cultura pop e dell’intrattenimento, nonché dei social network. “Di nuovo?” vi chiederete, se avete letto la scorsa newsletter. Sì, signori, siamo ancora qui.
Partiamo dal presupposto che, quando Simonetti dice che siamo nell’epoca della semplificazione, ha ragione: la comunicazione online è basata sull’immediatezza, a costo di sacrificare la complessità anche nei campi dove sarebbe necessaria. È lo strumento principale di quello che definisce “pop”, termine con cui forse si riferisce al mainstream. In parte, Simonetti sembra attribuire ai critici i difetti dell’attualità: autoreferenzialità, narcisismo, infantilismo; ma è un’autocritica debole.
Simonetti parte dall’assunto che la critica letteraria sia stata superata perché sostituita da forme di comunicazione più facili e appetibili per il pubblico, all’interno di un sistema volto ormai “all'intrattenimento puro e semplice, o all’adesione alle mode del momento, o ad altre belle cose per cui la critica è solo kryptonite”. I social sono corresponsabili della “delocalizzazione della critica e della letteratura più esigenti”, grazie agli “interventi carismatici ma incompetenti di popolari e ignorantissimi influencer”. Sull’ignoranza dei book creator batteva anche Mario Baudino nel numero di TuttoLibri dell’1 marzo, e la motivazione non è difficile da rintracciare: “quando, nel pop, il consumo diventa la forma centrale dell'esperienza culturale”, afferma Simonetti, “non serve più un esperto a spiegarci come funziona l’opera d'arte, cosa distingue il bello dal brutto, l’originale dallo stereotipo”.
Quello che insomma la critica letteraria teme è la perdita di potere, la caduta del ruolo di vate che guida — “educa”, come dicevo nella scorsa newsletter — il popolino. In tutto questo c’è però un cortocircuito logico: nessun book creator ha mai preteso di fare critica letteraria — esclusa la sottoscritta a diciassette anni, evidentemente — mentre i critici letterari lamentano di essere stati spodestati dagli ignoranti, come se fossero costretti a condividerne gli spazi. Ma, ecco, no: i critici letterari scrivono sui giornali; i book creator parlano sui social, si rivolgono a un altro pubblico e, soprattutto, parlano di altri libri, perlopiù snobbati dai critici perché indegni di essere recensiti — nonostante, o forse proprio perché, siano quelli che vendono di più.
Chi è che ruba spazio alla “perizia tecnica” dei critici letterari, quindi? Risponde lo stesso Simonetti: critici-scrittori dalle opinioni depotenziate che puntano solo a “evitare inimicizie”, e tuttologi. Di conseguenza, sono gli stessi giornali su cui scrivono i critici ad aver tolto loro autorità, preferendo a questi le opinioni “comunicabili”, inoffensive, personali, e abolendo i pareri negativi. Anche Gilda Policastro lamenta che le è stato chiesto di togliere la parola mnestico da una recensione perché “il lettore non deve durar fatica”, confermando la tendenza a semplificare, in primis dei media culturali.
In questo contesto, i book creator hanno un ruolo più marginale di quello che sembra, ma vanno inseriti a prescindere nel discorso in quanto rei di mali universali.
Che la critica letteraria non importi più a nessuno, poi, è tutto da dimostrare: il pubblico interessato esiste — nel mio piccolo, quando ne parlo su YouTube ricevo sempre riscontri entusiasti — ma probabilmente non sono più i giornali i veicoli principali, quanto i libri di saggistica e i paratesti a corollario dei romanzi. Fatte le dovute differenze tra creator e critici, e assodato che le due professioni non devono essere confuse, si potrebbe addirittura cercare di spostare la critica sui social o, in generale, in rete, proprio perché le professioni hanno bisogno di evolversi senza che questo voglia dire necessariamente abdicare alla complessità. Ma la critica, arroccata nelle torri eburnee e nelle elitarie convinzioni piccolo-borghesi, rifiuta qualsiasi trasformazione e poi piange i tempi cambiati.
Alla fine dell’articolo, Simonetti fa un invito: “Servono più che mai disponibilità all’ascolto, voglia di capire e magari di cambiare — se ci si sente autentici lettori e non semplici followers”. Auguriamo lo stesso ai critici letterari.
Nell’articolo successivo Mario Baudino dice, con grande onestà intellettuale, che le recensioni sulle pagine culturali non aiutano le vendite, scavallate dal passaparola dal vivo o online. L’influenza dei giornali, come da anni sa chi lavora nel settore, è nulla, ma serve soprattutto perché solletica l’ego degli autori.
Nel pezzo di Baudino c’è un’affannata rincorsa all’utilità della critica all’interno di un sistema che l’ha messa da parte: ne esce fuori un canto del cigno che suscita tenerezza.
Baudino sottolinea che l’autorità del critico è riconosciuta anche dal web — l’opposizione dicotomica quanto miope vuole da una parte il web dall’altra la stampa tradizionale, come se di bravi giornalisti che scrivono per ottime testate non ce ne fossero anche su TikTok — e che le pagine culturali “hanno lettori di alto profilo, quelli che poi tengono su il mercato del libro” (le parole sono di Gianluca Foglia, direttore editoriale del gruppo Feltrinelli).
Cosa si intenda per lettori di alto profilo si può presto immaginare: lettori non di libri di genere, a prescindere da quanti volumi leggano (e dire che le lettrici più accanite sono quelle del romance, soprattutto da edicola, capaci di leggere anche una o due centinaia di Harmony all’anno). Se pensiamo a chi acquista gli inserti culturali, vengono in mente uomini dai quaranta/cinquant’anni in su: siamo sicuri siano loro a reggere il mercato del libro?
“Attenti quindi a dar per morto il critico militante. È sommerso dal grande frastuono, ma a quanto pare gli editori continuano a cercarlo” conclude Baudino, lasciando quasi intendere che la critica rimane in vita solo per un atto caritatevole dell’editoria, e a patto, certo, che scriva recensioni positive. Allora, ribadisco il problema è la dipendenza dal sistema. Se la critica vuole sopravvivere, se non vuole farsi fagocitare dal “pop” e dettare le sue leggi, tornare ad analizzare, stroncare, riacquisire autorità, dovrebbe distaccarsene e diventare indipendente. Gli strumenti ci sono: l’elasticità mentale, forse, un po’ meno.
Il video della settimana
Sabato ho parlato dello stesso argomento in un video su YouTube che trovate QUI. Ho ampliato un po’ di più la discussione, quindi se vi va fatemi sapere anche lì cosa ne pensate!
Le ultime newsletter
Le community salveranno i libri ma l'editoria non è pronta per questo discorso
Essere informati significava non perdere il controllo
Come lo Spritz del venerdì ha alterato la chimica del mio
Una newsletter divertente che non scriverò mai più

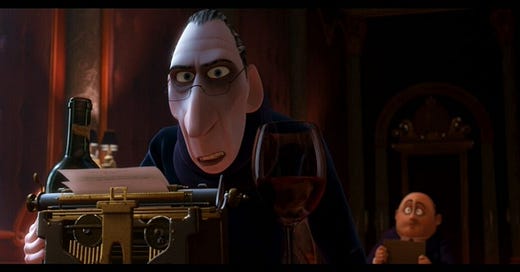



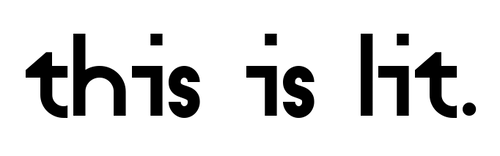
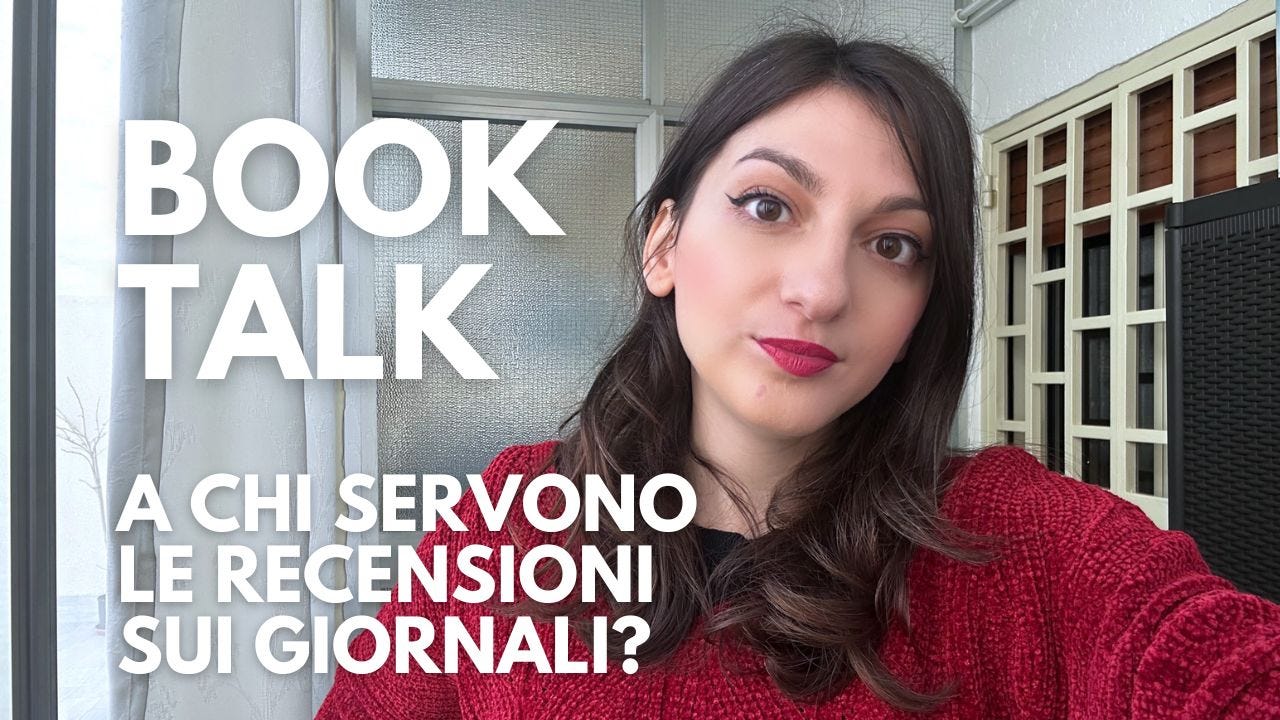
Hai sollevato un problema decisamente importante, la percezione della perdita di potere da parte di una classe di intellettuali che si rifiuta di dialogare con ciò che è altro da sé. Punto di vista particolarmente miope, perché vorrei sapere cosa ne sarebbe dell'editoria se i vituperati booktoker smettessero di interessarsi ai libri per dedicarsi ad altro.
Beh è una cosa non da poco.
Come te, ho visto anche il video su YouTube, sono in parte d'accordo con quanto scritto, sia da Simonetti che da Baudino. La questione dell'impoverimento del linguaggio e della semplificazione dei contenuti, esiste ed è figlia di una serie di questioni profonde e vecchie. Sicuramente la questione televisione, prima, e social, dopo, hanno peggiorato il tutto.
Quello sul quale non concordo è questo "piangersi" addosso. La critica, ed Ilenia l'ha dimostrato, piace, interessa ed avvince. Ovviamente non può più essere fatta come veniva pensata 20 anni fa. Non tutti, io in primis, mero informatico, hanno le conoscenze, la cultura e gli strumenti per seguire una critica di un certo livello.
Questa però può diventare un percorso graduale. Si possono avvicinare le persone, farle appassionare, creare contenuti che possano essere fruiti da tutti e tramite questi, magari col tempo e con cura, mettere a disposizione dei percorsi di crescita comune.
Il problema, a mio avviso, è voler continuare a volere una critica elitaria, chiusa ed incomprensibile ai più. Che senso ha in un mondo di 8mld di persone, avere dei testi comprensibili ed apprezzabili solo da una minima percentuale? Che senso ha scagliarsi contro generi letterari quando la realtà è che, soprattutto in Italia, non vi è quasi cultura della lettura? E non parlo di lettori forti con oltre 50 libri ogni anno, ma parlo di lettori minimi, senza neanche uno, due, tre libri letti, fuori dall'ambito scolastico.
C'è anche un altro fattore che a mio avviso non va sottovalutato. Il mezzo di comunicazione utilizzato, il tempo di assorbimento dello stesso e la necessità che, il fruitore, ha di quel dato contenuto. Oltre all'altissimo tasso di analfabetismo funzionale che è presente in Italia.
Insomma, stare a lamentarsi e sbattere i piedi non credo sia la soluzione, neanche arrendersi e dare la colpa ai digital creator. Piuttosto un esame, a mente lucida, del perché certe cose non funzionino più.